Era una domenica d’autunno, il 26 ottobre 1890, quando Firenze salutò per sempre Carlo Lorenzini, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Carlo Collodi.
Aveva 64 anni e lasciava un vuoto silenzioso nella cultura italiana. Nessuno, forse, immaginava che proprio quel giorno sarebbe nato un mito destinato a varcare i confini del tempo e del mondo: Pinocchio, il burattino di legno che voleva diventare un bambino vero.
Oggi, a 135 anni dalla sua morte, Collodi continua a parlare con la voce della sua creatura, ricordandoci che tra verità e bugie, disobbedienza e redenzione, si gioca la più antica delle avventure umane: quella di imparare a essere se stessi.

Carlo Lorenzini nacque a Firenze il 24 novembre 1826, primogenito di una famiglia modesta: il padre Domenico era cuoco, la madre Angiolina domestica di una nobile famiglia di Collodi, il borgo toscano a cui Carlo decise in seguito di ispirarsi per il suo nome d’arte.
Fin da giovane mostrò una spiccata intelligenza e un’ironia tagliente. Dopo aver frequentato il seminario di Colle di Val d’Elsa, abbandonò presto la carriera ecclesiastica per dedicarsi al giornalismo e alla scrittura.
Fu patriota e volontario nelle guerre d’indipendenza, cronista attento e penna satirica. Fondò testate come Il Lampione e Lo Scaramuccia, dove ironizzava sui costumi e sulla politica dell’Italia post-unitaria.
Ma dietro il tono arguto si nascondeva un profondo senso morale: Collodi credeva nella formazione, nell’educazione e nella libertà come strumenti di emancipazione personale e collettiva.
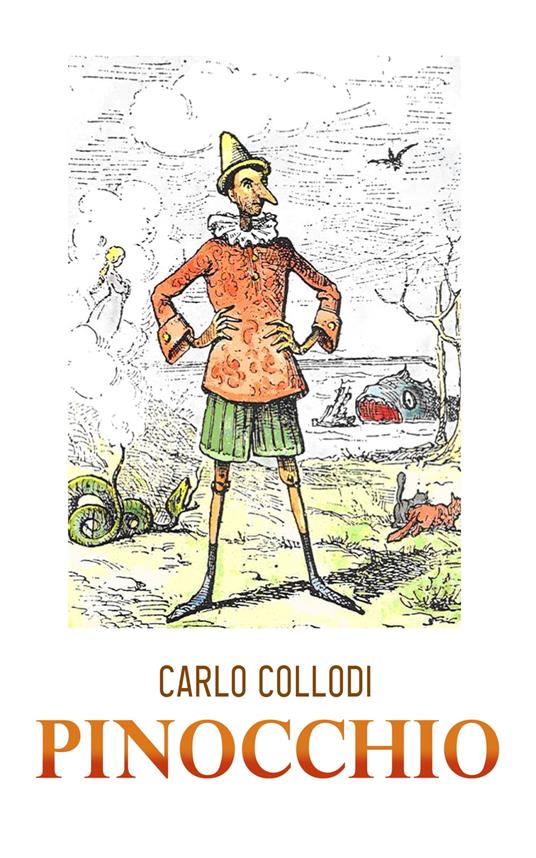
Fu quasi per caso che Collodi si avvicinò alla letteratura per ragazzi. Collaborando con l’editore Felice Paggi alla realizzazione di testi scolastici, scoprì un modo nuovo di comunicare: un linguaggio diretto, vivace, accessibile.
Nel 1881, sulle pagine del Giornale per i bambini, iniziò la pubblicazione a puntate de La storia di un burattino.
Quel racconto, pensato come un semplice divertimento pedagogico, si trasformò presto in un fenomeno.
Due anni dopo, nel 1883, vide la luce il volume completo: “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino.”
Una fiaba che non assomigliava a nessuna delle precedenti. Ironica, cruda, dolce e inquietante allo stesso tempo.
Pinocchio era un personaggio vivo, irrequieto, disobbediente e umano, capace di sbagliare e imparare. Collodi non voleva scrivere una morale, ma raccontare la crescita, con tutte le sue cadute e redenzioni.
Il suo linguaggio era intriso di realismo toscano e filosofia universale, una miscela che avrebbe reso la storia immortale.
-1761467803578.jpeg)
Il 26 ottobre 1890, Carlo Collodi morì improvvisamente nella sua abitazione in via delle Belle Donne a Firenze.
La notizia passò quasi inosservata: la stampa dell’epoca dedicò poche righe a quel “giornalista e autore di libri per l’infanzia”.
Eppure, nel silenzio di quella giornata autunnale, nasceva un mito che avrebbe superato i confini italiani.
Oggi Collodi riposa nel cimitero monumentale di San Miniato al Monte, a Firenze, in una tomba che porta incise poche parole ma racchiude un universo intero di fantasia.
Nel borgo di Collodi, invece, la sua memoria vive nel Parco di Pinocchio e nella Fondazione Nazionale Carlo Collodi, istituzioni che custodiscono e diffondono la sua eredità letteraria e morale.

A distanza di 135 anni, Pinocchio resta una delle opere più tradotte e lette al mondo – oltre 260 lingue e dialetti – e continua a ispirare adattamenti teatrali, cinematografici e artistici.
Dalle illustrazioni di Enrico Mazzanti ai film di Walt Disney e Matteo Garrone, la sua storia è diventata patrimonio universale.
Ma ciò che rende immortale l’opera di Collodi non è solo la fama. È il messaggio.
Pinocchio non è una semplice fiaba morale: è una metafora dell’essere umano, della libertà di scelta, del desiderio di diventare “veri”.
Collodi ci insegna che la verità non è mai data, ma conquistata — passo dopo passo, errore dopo errore.

Nel 2025, il messaggio del burattino di legno è più attuale che mai.
In un mondo in cui le bugie viaggiano veloci quanto la tecnologia, Pinocchio ci ricorda che crescere significa assumersi la responsabilità delle proprie parole e delle proprie azioni.
Come scrisse lo stesso autore in una lettera a un amico:
“Il burattino sono io, sei tu, è ciascuno di noi quando si smarrisce e poi ritrova la strada.”
Nel giorno del 135º anniversario della sua morte, l’Italia e il mondo non ricordano solo uno scrittore, ma un artigiano di sogni e verità, capace di parlare ai bambini di ogni tempo e agli adulti che non hanno smesso di cercare se stessi.








